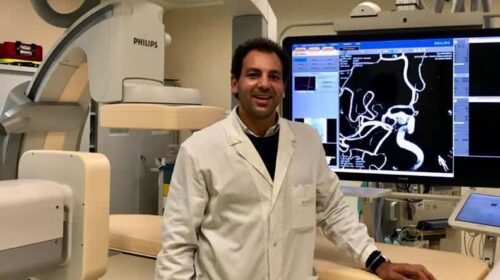L’11 gennaio di 24 anni fa a Milano moriva Fabrizio De Andrè
Accadde oggi: era l’11 gennaio del 1999, 24 anni fa, quando a Milano morì il cantautore Fabrizio De Andrè. Aveva 59 anni. Nasce da una famiglia della borghesia genovese il 18 febbraio 1940, nel quartiere genovese di Pegli, in via De Nicolay 12. Adolescente curioso ed irrequieto, matura la passione della musica fin da bambino, fin da quando, si dice, chiede al maestro di violino che i genitori gli hanno affiancato di suonare per lui: scopre ben presto il jazz (che suonerà, tra gli altri, con gli amici della “scuola genovese” Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli) e il francesce Georges Brassens, del quale si innamora subito, ricavandone una grande ispirazione anche per le idee politiche. Fabrizio, un “anarchico individualista”: è così che ama definirsi. Da quando, all’età di diciassette anni, si iscrive alla Federazione Anarchica Italiana di Carrara, la politica resterà una delle sue grandi passioni, tanto da impregnare densamente tutta la sua produzione artistica. Anche se, come dice Francesco Guccini di se stesso, Fabrizio non farà mai “canzoni politiche” in senso stretto: più semplicemente, le sue canzoni parlano di politica “perché parlano della vita, delle idee, degli uomini”. Perché la politica, che lo si voglia o meno, si occupa di noi, anche quando noi non vogliamo occuparcene, anche quando la sentiamo lontanissima.
Il successo non arriva prima del 1967, tre anni dopo l’uscita del disco “La canzone di Marinella”, quando Mina interpreterà la struggente ballata che aveva dato il nome al disco. Il suo primo vero album, però, è ritenuto da tutti “Volume I” (1967): gli seguiranno “Tutti morimmo a stento” (1968), “Volume III” (1968) e “Nuvole barocche” (1969). Siamo a quello che oggi viene potremmo chiamare “il primo De André”, quello delle ballate in rima, delle ambientazioni storiche, delle narrazioni goliardiche. Il brano di apertura di “Volume I”, “Preghiera in gennaio”, è scritta per l’amico suicida Luigi Tenco: “Signori benpensanti/ spero non vi dispiaccia/ se in cielo, in mezzo ai santi/ Dio, tra le sue braccia/ soffocherà il singhiozzo/ di quelle labbra smorte/ che all’odio e all’ignoranza/ preferirono la morte”. Versi durissimi nei confronti di una morale cattolica rigida e bigotta che condannava- a continua a condannare- tutto ciò che non vi si allinea ed, in particolare, il suicidio; ma anche versi di grande compassione, empatia, dolcezza. Tutta la produzione di Fabrizio De André sarà così: schierata, appassionata, diretta e al tempo stesso delicata, sussurrata, suggerente. Tutte le sue canzoni saranno storie: storie umane. Di amore, di guerra, di bellezza, di morte. Di debolezze, sopratutto. Di meschinità, di povertà e di miserie. Di condanna, per il potere in tutte le sue sfaccettature, e di pietà, per gli emarginati.
E’ timidissimo, Fabrizio: fino al 1975 non accetta di esibirsi sul palco e anche dopo, nonostante l’esperienza maturata negli anni, continuerà ad avere paura, a sottrarsi, a nascondersi (“Perché scrivo? Per paura. Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo di me. O anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile”): anche per questo motivo comincia a bere, “due bottiglie di wisky al giorno, da quando ho 18 anni”. “Ci si fa l’abitudine ai concerti. Hai mai visto gli orsi polari dentro i recinti degli zoo? Sicuramente soffrono per i primi anni, ma alcuni di loro sono arrivati a compiere il ciclo naturale della loro vita. Sono morti vecchi come i loro fratelli liberi fra i ghiacci dell’artico. La differenza è che loro, per quella vita di merda, non sono stati pagati”: eccolo, Fabrizio. Ironico, tagliente, ma anche empatico, sensibile, attento.
La sua discografia non è numerosissima: a quelli già nominati si aggiungeranno, tra il 1971 e il 1996, 10 dischi (“La buona novella“, “Non al denaro, non all’amore né al cielo”; “Storia di un impiegato”; “Canzoni”; “Volume 8”; “Rimini”; “Fabrizio De André”; “Crêuza de mä”; “Le nuvole”; “Anime salve”). Lungo i quarant’anni di carriera collabora con tantissimi altri artisti (da Ivano Fossati a Massimo Bubola, da Mauro Pagani a Francesco De Gregori, passando per Nicola Piovani, solo per dirne alcuni) sia per le musiche che per i testi: le canzoni di cui il cantautore genovese è l’unico autore (testo e musica) sarebbero infatti solamente otto. Eppure, anche nelle collaborazioni e pur attraversando fasi artistiche molto lontane l’una dall’altra, lo zampino di Fabrizio è inconfondibile: “Cercava disperatamente complimenti” dirà l’amico Paolo Villaggio al programma Rai “La storia siamo noi”, e non che non ne abbia- meritatamente- avuti.
Dopo la pubblicazione di quello che sarà il suo ultimo album in studio, “Anime salve”, la scrittrice Fernanda Pivano (traduttrice, tra l’altro, dell’”Antologia di Spoon River“, il libro di Edgar Lee Masters cui è ispirato l’intero concept album di “Non al denaro, non all’amore, né al cielo”) consegna a Fabrizio De André il Premio Lunezia per il valore letterario del testo di “Smisurata preghiera”, definendo Fabrizio come “il più grande poeta in assoluto degli ultimi cinquant’anni in Italia”, “quel dolce menestrello che per primo ci ha fatto le sue proposte di pacifismo, di non violenza, di anticonformismo”, aggiungendo che “sempre di più sarebbe necessario che, invece di dire che Fabrizio è il Bob Dylan italiano, si dicesse che Bob Dylan è il Fabrizio americano”. Incentrato sul tema della solitudine, “Anime salve” è un viaggio intenso dentro l’emarginazione: si incontrano rom, marinai, transessuali; ci sono gli ultimi, gli appartenenti alle minoranze, di qualunque tipo esse siano; c’è, dedicata a loro, la canzone che più di tutte potremmo definire il “testamento spirituale” di Fabrizio (e che è proprio la “Smisurata preghiera” che ha incantato Fernanda Pivano): “Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria/ col suo marchio speciale di speciale disperazione/ e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi/ per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità”. Quella verità che De André non cercherà mai di afferrare attraverso lo sguardo dall’alto, il giudizio, la sintesi, la definizione: la verità che sarà piuttosto descritta attraverso gli sguardi degli uomini, le loro storie, i dettagli del loro cuore, gli spazi dei loro errori.
Sarà questa attitudine, probabilmente, che contribuirà alla “santificazione” post mortem e farà di Fabrizio una specie di santino, appunto: qualcosa che non è criticabile, che non può non essere amato, che non può non piacere. Gli saranno intitolate scuole di ogni genere e grado, come l’Aula “Fabrizio De André” della Facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università di Genova, strade, piazze, parchi (fino all’etichetta di un vino, alle insegne di molti negozi, persino un’ambulanza). Santificazione che, certamente, è sempre sbagliata: proprio perché siamo uomini abbiamo il dovere di pensare, criticare, discutere. Di dire che una cosa non ci piace. Del resto, questa santificazione, come dirà più volte la moglie Dori Ghezzi, non sarebbe piaciuta neanche a lui.
E sono proprio le parole di Dori che la rivista Rolling Stones prende al balzo, nel 2011, per scrivere un controverso numero dal titolo “De André giù dall’altare”: il cantautore viene descritto sopratutto nella sua vita privata, se ne raccontano gli eccessi, le debolezze, le meschinità. Dopo la rivista americana, in tanti si sentono legittimati a smontarne il personaggio, infangarne la figura: si comincerà a dire che fosse un ipocrita perché “parlava dei poveri ed aveva la villa”, che fosse un ubriacone, un violento, misogino, antipatico, vigliacco. Nessuno che ricordi, ad esempio, l’”uomo” Fabrizio durante e dopo il rapimento da parte dell’Anonima sequestri sarda: all’indomani della liberazione, dopo quattro mesi di prigionia trascorsi insieme alla moglie Dori Ghezzi, De André tracciò un racconto pacato dell’esperienza (“[…] ci consentivano, a volte, di rimanere a lungo slegati e senza bende”), ebbe parole di pietà per i suoi carcerieri (“Noi ne siamo venuti fuori, mentre loro non potranno farlo mai”), e nel 1991 firmò una domanda di grazia, rivolta al Presidente della Repubblica, nei confronti di uno di loro, un pastore condannato a 25 anni di prigione. I mandanti, invece, non li perdonò mai.
E comunque, anche se tutte le accuse fossero vere, questo sarebbe l’uomo, e non l’artista. E mentre- forse- si può rimproverare ad un uomo politico di non essere per primo come vorrebbe che fossero gli altri, questo è insopportabile per un artista. Perché un artista, anche quando cerca di indicare una via, non ha mai la presunzione di avere la verità in tasca: è una verità fatta di bellezza, di poesia, di emozioni. E come possono le emozioni, umane e fragili per definizione, essere granitiche? “Che sollievo leggere queste considerazioni (del Rolling Stones, ndr), anche se pronunciate con colpevole ritardo. Ma meglio tardi che mai. Negli anni Settanta il Bel Paese era funestato dai figli ingrati della borghesia pasciuta e benestante, teorici dell’armiamoci e partite, che hanno riempito migliaia di teste di ideologia tragica e funesta. Oltre a rappresentare ben poco dal punto di vista della ricerca sonora, quasi nulla li differenziava dai cantanti del Festival di Sanremo, se non la verniciatura di rosso sulla rima baciata cuore-amore: Fabrizio De André era uno di loro, come l’altezzoso De Gregori, l’avvelenato Guccini, il sopravvalutato Vecchioni. Borghesi, benestanti, ricchissimi, indifferenti alle vicende di quel proletariato che spesso citavano a sproposito nei loro testi” scriverà Il Giornale.
Dal canto nostro, crediamo sia giunto il momento di ristabilire le giuste proporzioni: che cos’è che è importante? La vita privata di un artista, o la sua opera? Perché sull’opera di Fabrizio De André non si possono avere dubbi: può non piacere, certo, ma non se ne può non cogliere il valore. Valore che è letterario e linguistico perché i suoi testi sono un tributo alla parola e all’arte di usarla, nonché alla bellezza dei dialetti e delle lingue minoritarie che la società dei consumi sta massacrando e relegando all’oblio. E’ valore politico, e non perché si definisse anarchico, quanto piuttosto per l’umanità profonda che sottende a tutti i brani: un’umanità allargata, nel senso ampio di “appartenente all’essere umano”. Perché, per usare le parole di un commediografo latino: “Homo sum et nihil alienum a me puto” (“Sono un uomo e nessun fatto umano è distante da me“). Fabrizio era così, nel senso che sono così le sue canzoni, perché parlano della vita e della morte, del sogno e dell’amore, della guerra e del sangue, della viltà, dell’errore. Ma mai della dimenticanza. “Importante è amare e conoscere: non l’aver amato, non l’aver conosciuto” avrebbe detto Pier Paolo Pasolini.
E l’ascolto di tutta l’opera di Fabrizio è conoscenza continua, perché è scandagliare nelle profondità e nelle mille sfaccettature dell’essere umano, conoscere gli altri, conoscersi. Fabrizio è nelle sue canzoni, e da nessun’altra parte. Usare gli aspetti personali per infangare- e non demistificare, attenzione- un uomo è un atto vile. Per fortuna le canzoni di Fabrizio restano, al di là della sua vita e al di là delle polemiche, e quando abbiamo voglia- o bisogno- che qualcuno ci accarezzi il cuore, basta prendere una sua canzone e chiudere gli occhi, in barba ai cinici e ai detrattori.